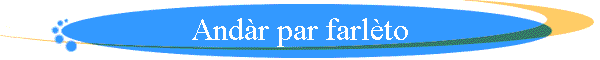
|
|
|
Il campanile della Posta è implacabile come il giudizio di Dio nella valle di Giosafat: al quinto dei rintocchi programmati devi esserti lasciato alle spalle il caldo del paglione. E’ permesso indugiare, ma non per molto, solo quando le grondaie cantano la canzone della pioggia; allora ti sfugge istintivo un sospiro che sarebbe forse peccaminoso pensare sia soddisfazione, che lavoro e preghiera sono sacri come dice Don Arcangelo; ti volti su un fianco, ma con discrezione, che il chiasso delle foglie di granoturco che consumano la tua stanchezza non svegli il pòpo che dorme nella culla di fianco al letto. Puoi perfino permetterti di sognare che di fianco a te giaccia il tuo uomo, che invece è partito per la Francia quando aveva ancora in bocca gli avanzi della festa di San Rocchetto (alla quale il narratore dedicherà, forse, in seguito una memoria). Puoi pensare all’ultima sera passata assieme a lui e noi ti perdoniamo la lacrimuccia che ti asciughi con la manica della camicia e non diremo nulla della tua perdonabile debolezza alla suocera che in questo momento, pioggia o non pioggia, sta trafficando rumorosamente in cucina. La scena cambia radicalmente quando il tempo è bello o anche solamente discreto. Se non lasci il letto in tempo sembra che tutte le forze disponibili si coalizzino contro di te: incomincia la sveglia, che la suocera, trascurando il comodino, ha messo a bella posta nell’angolo opposto della stanza per obbligarti ad uscire dalla cuccia. La sveglia, teutonica, gigantesca, fa un chiasso in grado di destare tutto il paese e continua implacabile fino a quando il palmo della tua mano non si abbatte, assieme ad una giaculatoria, sulla sua sommità. Se non si trattasse di un oggetto sacro e venerato per essere stata acquistata dal defunto suocero a Bremen in Germania ad inizio secolo, si sarebbe tentati di convincerla al silenzio con un colpo di martello in un posto segreto che conosco io. Messe a tacere la campana della Posta e la sveglia, inizia il concerto del mattino: intervengono in contemporanea il pupo e la suocera. Il pupo (suona meglio “pòpo”) strilla perché ha fame e perché è bagnato fradicio; la suocera perché è tardi; la Moretta muggisce dalla stalla reclamando la colazione e il gallo le fa da controcanto nel cortile. Il gatto, per fortuna, non miagola come di consueto, ma, beato lui, dorme. Io lo so perché: stanotte ha combinato un chiasso maledetto rovesciando il mondo mentre inseguiva un topo. Adesso è sazio. Signore fammi vivere finché vedrò un gatto lavorare e poi accoglimi pure nel tuo santo paradiso. E adesso svelti, e poche chiacchiere, che ci sono ancora molte cose da sbrigare prima di partire per i monti a raccogliere il “farlèto”. La suocera prepara due belle fette di polenta e formaggio e le avvolge… ma dove sarà finito quel bel foglio di carta da zucchero color blu che mi ha regalato il Mario della cooperativa… La borraccia è piena di acqua fresca, e fresca resterà essendo fatta, la borraccia intendiamo, con l’involucro panciuto di una zucca che assomiglia a quella appesa al bastone di San Rocco. Dal fondo delle scale sale ancora una volta un muggito di protesta che reclama inequivocabilmente una bracciata di fieno, ed ecco l’occasione buona per pulire il “soccàle” , sorta di roggia sistemata strategicamente sulla verticale della coda delle mucche e che, proprio per tale dislocazione, ne accoglie gli escrementi caldi e fumanti (suona meglio “boàzze”). Gli escrementi, mischiati al farlèto che funge da lettiera delle bestie da stalla, finiscono nella carriola con la quale vengono trasferiti, appena fuori dal paese, nella “pozza” che è deposito personale di ciascuna famiglia, dove gli escrementi matureranno, e con essi matureranno le zucche gialle e saporite che sopra vi crescono. Per completare i lavori nella stalla servono due secchi d’acqua per abbeverare gli animali e così le “signore vacche” sono a posto e le “povere donne” possono finalmente andare a lavorare. Il narratore ha ceduto al piacere di scrivere questi ultimi periodi perché può far rivivere ormai solo con i ricordi un mondo nel quale nessun sacco di plastica deturpava i paesaggi lacustri e fluviali, dove la raccolta differenziata dei rifiuti non era decretata con delibere del Consiglio Comunale, ma dalle esigenze di cicli naturali della natura sedimentati da millenni; dove erano la luce del sole, la pulizia dell’aria e dell’acqua a mutare in residui organici quanto gli uomini avevano reimmesso nel ciclo della vita. Il lettore ci perdoni il continuo intercalare dei pensieri: ci sentiamo a ciò giustificati perché, era necessario nel frattempo dar modo alla suocera di riempire Il “prosàc” , così detto il sacco da montagna, in fondo al quale fanno da letto due “strazòni”, uno grande per l’anziana e uno piccolo per la “tòsa”. Il dubbio per l’eccessivo numero di termini in vernacolo ci suggerisce di precisare, soprattutto a beneficio del lettore giovane, che la “tòsa” è la ragazza giovane – la nuora – e che gli strazòni sono dei riquadri di tela di canapa grezza con il lato di circa un metro di lunghezza; ai vertici del quadrato sono fissate le corde per legare il carico. Quel che faccia la tòsa nel frattempo è intuibile, salvo che per un particolare sul quale è opportuno per ragioni storiche soffermarsi. Diciamo pertanto che, dopo uno svelto allattamento ed un’altrettanto svelta pulizia delle parti intime del pòpo, la tòsa sfila da un’asta fissata al camino della stufa una lunga misteriosa fascia di cotone bianco, larga circa otto centimetri, alle cui estremità penzolano due lunghi lacci: è il panisèlo, uno dei più raffinati strumenti di tortura per neonati in uso all’epoca di cui si parla. E’ bello, è caldo il panisèlo, e il pòpo se la gode un mondo mentre gli viene fissato alla vita con uno dei due lacci. Il discorso diventa più serio – per il pòpo s’intende – quando la fascia comincia ad avvolgere strettamente fianchi, cosce, ginocchi, polpacci, piedi ed il secondo laccio blocca inesorabile senza scampo la piccola mummia alla quale è stato ridotto. Per fortuna gli strilli non si articolano in parole, che, altrimenti, se ne sentirebbero di quelle da far impallidire Don Arcangelo. I pannolini morbidi e “sempre asciutti”, “usa e getta”, per “pipì da campioni”, il talco profumato, i giocattoli appesi alla culla e, soprattutto i pediatri che prescrivono gambe a ranocchio libere e felici, sono in un insospettabile futuro di là da venire. L’importante, sentenzia la suocera, è che cresca con le gambe dritte come quelle di suo nonno buonanima, e, se piange, gli si rinforzano i polmoni, e, se ha paura, gli passerà. La tòsa accenna un sì poco convinto e, fingendo di aggiustarsi il fazzoletto in testa, si asciuga una lacrima con il dorso della mano. Il campanile della Posta dichiara le sei e trenta. E’ il momento, prima di partire, di un pater, ave, gloria per cominciare bene la giornata e di tre requiem per ricordare i defunti. Ricordarsi di portare fiori al cimitero domenica alla prima Messa (in dialetto “Messa prima”, ore 6.30). Via che si parte. Il gatto prende posto sul paglione rimasto libero e si riposa di non so quale fatica; “mèmele” – la capretta – ridacchia dalla stalla un saluto, e il portone conferma tossendo la propria chiusura. L’aria è fresca e umida e le ombre della notte schiariscono pigramente sulla valle. C’è tempo prima della salita: si va quasi in piano sulla vecchia strada austriaca fino all’Acqua Morta. La fatica è leggera; si guardano per istinto le case emergenti di Montepiano e lo Spitz di Tonezza ancora indistinto nelle luci dell’alba, e in questo tempo senza tempo (zeitloses Zeitwort lo chiamano gli anziani del paese che conoscono tutti più o meno bene il tedesco), in questo momento che non è né giorno né notte e la temperatura dell’aria è mezza via tra il fresco della notte ed il calore del giorno, viene a galla la nostalgia. L’Astico accarezza le tue memorie e tu sogni di sognare, mentre le voci stridenti dei galli sfregiano il silenzio del mattino. Ancora nostalgia; la vecchia davanti, la tòsa dietro. Qualche frase breve e sommessa. Il ritmato, soffice calpestio degli scafaròti sulla strada sassosa. Molti silenzi. Più tardi, l’ansito per la fatica della salita, l’attenzione per le difficoltà del cammino ed il timore atavico di calpestare una vipera svuoteranno la mente e le parole saranno sostituite da sospiri, giaculatorie e rumori di sassi spostati dai passi lungo il ripido sentiero. Finalmente… finalmente la pòlsa, un sasso calcareo creato in illo tempore dal buon Dio e levigato nei secoli dalle piogge, dalle slavine, dai passi e dalle natiche degli uomini. Una manna per sedercisi e riposare (“polsàr”), per bere l’acqua fresca che esce dalla zucca come una benedizione, per far rinascere pensieri e parole, per pensare al pòpo che dorme a casa e al pòpo più grande che è in Francia a migliaia di chilometri a lavorare e quanto sarebbe bello che nella cassetta di ghisa delle Regie Poste davanti alla casa del Luciano, arrivasse oggi una lettera tutta per me. Carissima, raccontami tutto del bòcia, se è sano, se cresce, se strilla, se sta in piedi, se… e poi raccontami anche di te perché quassù in mezzo ai sassi viene una nostalgia da morire e non faccio altro che pensare all’ultima sera passata assieme dopo la festa di San Rocchetto… Fine del sogno; i sogni troppo lunghi; stancano; qualche volta bisogna perfino confessarli a Don Arcangelo e poi, alla lunga, scoprono la loro natura irrimediabilmente effimera. Così si riprende a salire, interminabilmente, passo dopo passo, respiro dopo respiro, fino al Méndarle che è il luogo adatto alla raccolta del farlèto. Lasciamo per un momento i nostri due personaggi al lavoro perché ci sembra importante ricordare a questo punto che essi rappresentano soltanto un campione esempio di umanità locale al lavoro; si vuol dire che, a quell’ora, molte donne stanno come loro camminando allo stesso modo, con medesimi o simili pensieri, sugli stessi o su diversi sentieri, e questo perché l’economia della valle è fatta di attività cicliche che scandiscono il trascorrere del tempo e sembrano ripetersi per l’eternità. Che tu lo voglia o no, il tempo del farlèto è tempo che invita a pensare e, anche se hai a disposizione le sole, modeste sollecitazioni costituite dai libri (non all’Indice naturalmente) della biblioteca parrocchiale, ti ritrovi ad essere filosofo per necessità e senza nemmeno saperlo. Pensi al tempo che passa come l’acqua dell’Astico, ai panni intrisi di lavoro che quell’acqua lava alle foci del Rio Solo, alla tua pena per l’incertezza delle stagioni, dalle quali dipende il cibo quotidiano, alle malattie che segnano un destino che, nella scarsità o nell’impotenza della scienza medica, è affidato per intero al buon Dio. Tu sai, questo è vero, che il tuo uomo è in Francia, ma qualche volta ti viene da dubitare che la Francia esista e che il mondo cessi di essere, oltre la sagoma del Cornetto, oltre la cuspide tondeggiante del Belvedere, oltre le modeste rocce che sovrastano San Pietro Valdastico, e la croce dello Spitz sembra suggerire e chiudere simbolicamente il tuo mondo e il tuo destino. Eppure fra quattro mesi, per Natale, dovranno pur tornare i nostri uomini. Torneranno dai Pirenei, dalla Svizzera, dalla Francia e voglio proprio chiederlo a Carlo di raccontarmi com’è fatto il mondo, Parigi, Lucerna, Berlino. Tanto so già quello che mi risponderà: Parigi? Mai vista. Credo l’abbiano costruita in pianura. Cosa ne puoi sapere quando lavori a duemila metri a spaccar sassi con la dinamite o in galleria a mangiar polvere. Con i quattro soldi che prendo c’è da pagar medico, veterinario, vestiti, sistemare la casa, un minimo di carne la domenica per tenere in forza i bambini. A proposito, sabato dovrebbe passare sul ponte il Vittorio becàro. Il polmone costa abbastanza poco, ma sempre troppo per i poveri diavoli. Sto sognando, lo so, e al mio sogno Carlo non risponde; ma io so cosa significa il suo silenzio: significa che quel poco che resta non basta neppure per un giro fino a Vicenza, altro che Parigi, e che in ogni caso si sa che quel poco che resta finirà in una cassettina di legno, tesoro nascosto sotto il paglione, a disposizione per un’emergenza che, quando si verificherà, non sarà mai abbastanza importante da mettervi mano. E’ già successo con il Toni ciabattino: un giorno la candela della vita si è spenta senza preavviso; si porta via il morto e, sotto il paglione, compare, intatta, inutilizzata, sofferta, sudata, la scatola del “tesoro”. Non è tanto un tesoro per quel che vale alla cooperativa: vale, lo si ripete, per quel che costa in termini di fatica, di sacrificio, di privazioni, di nostalgia e, qualche volta, anche in termini di malattia, di sangue e di morte. Torniamo a noi. Le due donne adesso raspano la terra con le mani nude e callose che si sollevano grondanti di piante del sottobosco: un intrico di rametti che copre il monte sotto l’ombra dei faggi, dei roveri, delle querce, delle rade betulle, mescolato alle foglie secche dell’autunno scorso e, talora, a fiori di stagione. Un mazzetto di ciclamini da portare davanti alla Madonna è una benedizione per la giornata. E’ questo il farlèto, abbondante, necessario, provvidenziale. E’ il “paglione” delle mucche e delle capre, il legante del concime che esse producono, un brano della nostra sopravvivenza. E’ giorno fatto. Il sole di settembre indugia oltre il crinale, ma la valle e la catena montuosa a occidente, oltre il fiume è allagata di luce. La raccolta è finita. Spartita tra i due strazòni, è stata legata strettamente ed il viso della vecchia si spiana. Escono dalla carta da zucchero le fette di polenta e la colazione ha l’aspetto di un premio per il lavoro eseguito. Si sente qualche richiamo, qualche avvertimento all’attenzione rimbalza più volte tra le rocce sottolineato dagli echi, e qualche strazòn fischia nell’aria scivolando, appeso ad un rampino di legno su uno dei tanti fili metallici che si intrecciano sui monti e trasferiscono i carichi a valle. Viene spontaneo fare il tifo per l’esito del precario percorso degli strazòni che non sempre si conclude felicemente alla stazione d’arrivo. Non sono infrequenti gli arresti del carico a mezza via o il disarcionamento e relativa caduta in valle; ferite dolorose e francamente immeritate dopo tanta fatica. Dicono, ma forse è una leggenda, che una volta il Marino che era un giovane svelto, magrissimo e nervoso quant’era magro, si arrabbiò tanto per uno degli incidenti appena narrati che, preparato un rampino di dimensioni adatte, vi si aggrappò e scese a tutta velocità lungo il cavo con le gambe tese avanti per colpire il carico fermo, riuscendo ad accompagnarlo felicemente a valle e che fu il farlèto stesso legato strettamente nello strazòn a fargli da cuscino (oggi lo chiameremmo air-bag) nel momento dell’impatto di fine corsa. Si dice anche – il narratore ha il dovere, e anche il piacere, di riportare dicerie e leggende – che qualcuno abbia sperimentato con esiti disastrosi l’uso di rampini di ferro, i quali hanno bensì il vantaggio di non fermarsi mai, ma, per contro, lo svantaggio di scivolare ad una velocità tale da distruggere il carico alla stazione di arrivo e, soprattutto, di spostarsi emettendo un fischio acutissimo ed un pennacchio di scintille improponibile per un’epoca nella quale i Canadair erano di là a venire. Una di quelle scintille sembra abbia illuminato i ricordi del narratore che, prossimamente, dedicherà qualche pagina alle memorie di un incendio che ha messo in crisi la vegetazione sopra il Rio Solo. Non tutte le zone sono servite da questi provvidenziali e avventurosi cavi; e questa è la situazione nella quale si trovano ad operare le due eroine del nostro racconto, che dovranno scendere a valle a piedi e prudentemente, ma quando il lavoro è concluso, anche la fatica sembra più sopportabile. Per il momento, mangiamoci polenta e formaggio e godiamoci questo cuculo che ci fa compagnia. Tempo scaduto: ancora un sorso d’acqua; uno alla vecchia, uno alla tosa. Borraccia vuota, mi raccomando, che non ci portiamo a casa pesi inutili. Forse sarebbe meglio dire che l’acqua è più leggera in pancia che sulle spalle, ma questa è una riflessione profonda del narratore che, qualche volta, sarebbe meglio si limitasse a raccontare senza aggiungerci del suo, ma, detto fra noi, farlo tacere, è un problema. La cronaca, per parte sua, ci fa sapere che gli strazòni, gonfi di farlèto, sono sistemati su un piano rialzato rispetto al sentiero e così basta accucciarsi a terra per trovarsi il carico proprio in corrispondenza delle spalle. Testa china sotto il peso, mani aggrappate ai lembi della canapa grezza che contiene la tua fatica mattutina, una flessione delle gambe e si è in piedi. Si scende prudentemente, la vecchia davanti, la tosa tre passi indietro. Si arriva alla pòlsa che serve ancora, ma non per riposare: questa volta è utile per riassestare il carico che si scompone durante il cammino. Chissà se il pòpo dorme… quell’altro starà spaccando sassi… dovrei soffiarmi il naso, ma come si fa…mi arrangio con la manica, mica posso portare il carico con una mano sola… ehi attenti a quel sasso in bilico, inciampata la scorsa settimana. Campanile della Posta, le nove, orario giusto, sole alto, ci sarà da sudare dall’Acqua Morta a casa, almeno trovassimo il Carletto con il carro come quindici giorni fa, no forse venti o più… il tempo passa che neanche te ne accorgi; caricato tutto sul carretto, una montagna di farlèto e via a spingere con poca fatica fino al paese. Grazie Carletto. Beata Vergine Addolorata! La tòsa in difficoltà così si esprime; a volerla chiamare imprecazione certamente si esagera, eppure non è una giaculatoria, lo si capisce dal tono della voce. Il Giovanni Corona certamente si sarebbe espresso in termini più impegnativi… Il fatto è che il carico si è incastrato in un ramo sporgente sul sentiero e la tòsa chiede aiuto alla suocera, la quale, senza scomporsi, pratica com’è del mestiere, consiglia una giravolta, una specie di balletto che risolve d’incanto il problema. Il narratore è convinto che un’imprecazione seria, spontanea ed autentica, pur se castigata, come per esempio “porca miseria” o “accidenti a te ramo delle mie scarpe”, avrebbe risolto in piena sicurezza sia il problema tecnico che quello psicologico, tenuto conto anche del fatto che Don Arcangelo non sentirebbe nulla essendo lontano un paio di chilometri in linea d’aria e, fosse anche vicino e sapesse per davvero come dichiara leggere nei cuori, è altrettanto vero che è duro d’orecchi. Opinioni del narratore sulle quali esprimiamo per intero le nostre riserve. Siamo all’Acqua Morta, Carletto non si vede e allora via verso casa. La vecchia strada austriaca è quasi piana e il sole si fa sentire, ma questo lo si era previsto e non conviene insistere. La strada è la stessa dell’andata; la differenza la fa il peso sulle spalle e la limitazione del panorama osservabile, condizionato com’è dalla testa china: niente Montepiano, men che meno lo Spitz, troppo alto perfino il campanile della Posta. Questo è il gradino davanti al Capitello della Jara dove non può mancare un’avemaria per il pòpo infante e una per il pòpo emigrante, e ti viene di chiedere scusa a Gesù per non poter alzare gli occhi fino alla sua faccia dolente. Eccoci al paese: sfilano sulla destra le pozze con le loro grandi zucche gialle; una minuscola discesa ombreggiata sul lato sinistro dalla chiesetta di San Rocco; sempre a sinistra il Capitello votivo fatto erigere per divozione da Giuseppe Recchia, seguito dal pollaio del Lino Chilon e a destra il vòlto che dà sul Cortivo. Eccoti finalmente sulla piazza principale del paese che con geniale ironia chiamano Piazza Tamarindo, dove ti sentiresti a casa, non fosse per la bravata di quel mattacchione dello Shuster, il calzolaio, il quale, afferrato un lembo del tuo carico, ti costringe ad una veloce piroetta. Scoppiettano le risate, lo scherzo è un classico, e Shuster, ormai pago, ti libera benevolmente. La tòsa tace; tiene gli occhi bassi, e il narratore che è, per propria natura e professione, curioso e maligno, crogiola il sospetto che, in un tempo definitivamente trascorso, sia corso del tenero fra loro due. Peccati veniali, beninteso, peccati che si risolvono senza residuo con appena tre pater-ave-gloria. Lasciamo chi narra alle proprie malignità e, noi che siamo seri, seguiamo la suocera che adagiati in terra i carichi, sale nel fienile (la tèza) e getta in basso alla tosa i due capi della fune che penzola dalla carrucola. All’estremità di uno dei capi c’è un gancio che la tosa fissa al carico che deve essere sollevato fino all’altezza della tèza facendo forza sull’altro capo. Una cosa che non fa difetto nel paese è la solidarietà nel tiro alla fune: chi è presente dà una mano senza badare all’età, al sesso e non è proprio il caso di parlare del censo. La tòsa si terge il sudore con la manica e beve l’acqua freschissima che sgorga perenne dalla fontana appena a due passi, di fronte all’osteria del Bepi Piépar. Ma si, permettiamole di sciogliere i nodi sottogola che fissano alla testa il tradizionale fazzolettone che portano tutte le donne, vecchie o giovani che siano. Perdoniamole anche il ciclamino che si affaccia alla fronte tra i capelli; l’avrà raccolto per farsi bella pensando al suo uomo che a quest’ora starà spaccando sassi in terra di Francia, ma forse questo l’avevamo già detto. Ciao tòsa, sei stata con noi per tutta questa mattina di lavoro e quasi ci dispiace vederti scomparire dietro al portone che, preceduto dalla risata sardonica di mèmele, tossisce ancora una volta la sua chiusura.
Eligio |
|
|